Invitiamo alla lettura di questo libro di Mauro Forno, docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Torino, che permette di rivisitare il variegato mondo delle missioni nel suo rapporto tormentato con la decolonizzazione.
L’Autore presenta la posizione della Chiesa e dei missionari di fronte alle conquiste dell’indipendenza dei Paesi del cosiddetto Te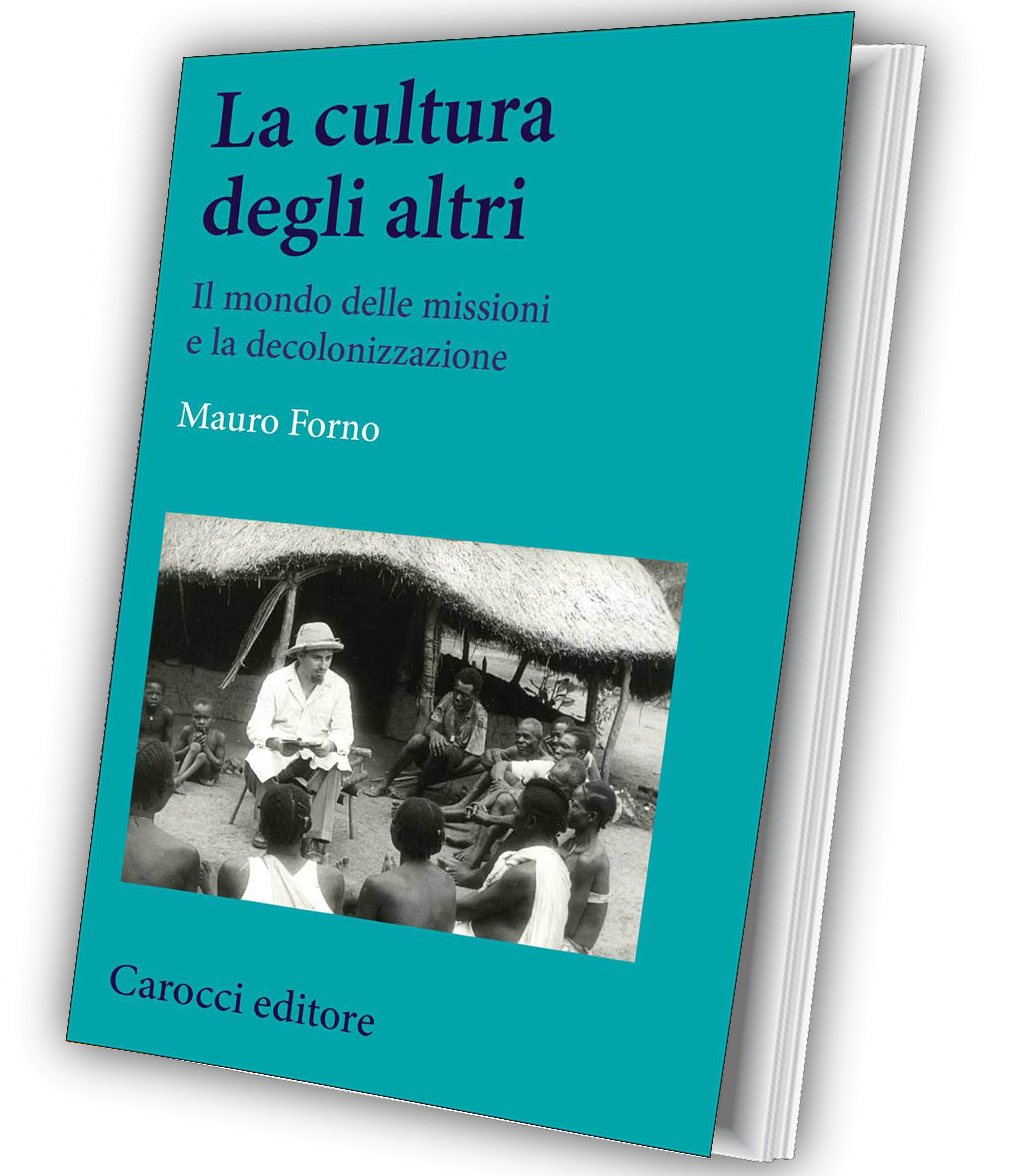 rzo Mondo, nei decenni che hanno preceduto e preparato il Concilio Vaticano II. Questi avvenimenti vengono inseriti nelle dinamiche e nelle tensioni mondiali ed ecclesiali, fra le quali la paura del comunismo e la competizione cattolica con il massiccio impegno dei protestanti in campo sociale.
rzo Mondo, nei decenni che hanno preceduto e preparato il Concilio Vaticano II. Questi avvenimenti vengono inseriti nelle dinamiche e nelle tensioni mondiali ed ecclesiali, fra le quali la paura del comunismo e la competizione cattolica con il massiccio impegno dei protestanti in campo sociale.
Mauro Forno mostra, poi, la difficile comprensione e recezione del Concilio Vaticano II e dei suoi fermenti teologici e pastorali; egli si sofferma, altresì, sulle reazioni e frustrazioni espresse dal mondo missionario che ha vissuto, nel post-Concilio, una crisi profonda d’identità e un calo importante delle vocazioni.
L’Autore invita, infine, a una comprensione nuova dell’evangelizzazione, imperniata sul rispetto della cultura dei diversi popoli.
Mauro Forno, La cultura degli altri. Il mondo delle missioni e la decolonizzazione, Carocci Editore, Roma 2017, 207 pp.
![]()
Il testo ci presenta l’intreccio dell’opera di evangelizzazione con i profondi mutamenti storici che hanno interessato, in quei decenni, il rapporto tra l’Occidente e i Paesi cosiddetti di missione. Questi ultimi vivevano, infatti, una profonda trasformazione dovuta al raggiungimento dell’indipendenza politica, alla decolonizzazione culturale ed economica e alla riscoperta delle proprie culture.
Le dinamiche ecclesiali ad gentes avevano risentito, nel passato, dei nazionalismi dei Paesi di origine dei missionari. Globalmente, però, i missionari avevano preceduto e preparato profeticamente gli eventi storici dell’indipendenza nei Paesi in cui operavano.
Era stata portata avanti, infatti, da parte delle congregazioni missionarie, la strategia della formazione scolastica, civile e religiosa delle popolazioni indigene; anche le iniziative sociali per lo sviluppo avevano contribuito a orientare i popoli verso una coscienza nuova e una responsabilità umana ed ecclesiale.
Lo sguardo dei protagonisti
Lo studio di Mauro Forno, realizzato attraverso un metodo storico rigoroso, ha utilizzato fonti inedite, quali le relazioni dei missionari delle principali congregazioni missionarie inviate ai rispettivi superiori e l’analisi dei reportages delle riviste missionarie che nel tempo avevano colto il malessere e interpretato i cambiamenti storici della decolonizzazione e l’aria nuova della primavera conciliare.
L’Autore mostra come le riviste avessero cambiato la loro linea editoriale, alcune in modo più marcato, dando più spazio agli avvenimenti sociali e storici dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Esse avevano cercato di liberarsi da una propaganda missionaria che era stata caratterizzata da racconti dai toni strappalacrime; tale stile era stato incoraggiato per ottenere aiuti economici da parte dei cristiani d’Occidente e aveva messo in ombra la legittimità delle culture e delle aspirazioni storiche dei popoli con i quali si entrava in contatto.
Queste fonti storiche, spesso inserite ampiamente nel testo, rendono accattivante la lettura e la comprensione globale dei complessi intrecci storici presentati dall’Autore.
Lo studio storico, infatti, viene in tal modo filtrato attraverso il fattore umano, cioè la lettura degli eventi fatta dai protagonisti della missione, e mostra quanto i missionari siano stati anch’essi figli del loro tempo, condizionati dalla propria cultura e spesso anche dai pregiudizi, duri a morire, nei confronti delle culture altre.
La cultura degli altri non contava
Paradossalmente proprio i missionari, che avevano promosso con dedizione e con sacrifici enormi l’elevazione culturale dei popoli ai quali erano stati inviati, espressero posizioni paternalistiche e atteggiamenti che rallentavano e quasi ostacolavano l’emergere di un episcopato locale, promosso invece vivamente da Roma.
Il Magistero e i Dicasteri romani, in una visione ecclesiale più globale degli avvenimenti rispetto a quella dei missionari, avevano, infatti, ben chiara l’esigenza di salvaguardare la presenza della Chiesa in molti Paesi, perché nel processo di decolonizzazione in corso, i governanti identificavano, in molti casi, l’Occidente e i missionari, che venivano espulsi indiscriminatamente.
Nella relazione centro-periferia mostrata in questo studio, la posizione del centro, cioè del Magistero e dei Dicasteri di Roma, appare più avanzata rispetto a quella dei missionari che vivevano l’esperienza della missione e condividevano la vita della gente, ma erano dotati di una formazione teologica e culturale che li rendeva refrattari ai cambiamenti in atto.
In effetti, i missionari avevano difficoltà a vivere con confratelli religiosi “di colore” e a rinunciare ai propri privilegi per integrarsi con il loro proprium in una realtà diocesana diretta da Vescovi locali.
I documenti citati dal libro esprimono la grande sofferenza dei missionari, la loro solitudine, il sentimento di essere incompresi e di ricevere ingratitudine.
Nell’articolata analisi storica vengono inoltre messi in evidenza le attese delle popolazioni, l’accoglienza e l’interpretazione della religione dei missionari quale “segreto” della loro civiltà e forza, la progressiva presa di coscienza dei limiti della cultura occidentale, poi, l’atteggiamento di difesa dall’aggressione della propria cultura e, infine, la rivendicazione della propria autonomia.
Viene sottolineato come si fosse rafforzato lo spirito critico delle popolazioni indigene, in particolare durante la Seconda guerra mondiale, di fronte alla loro implicazione nel conflitto che toglieva ai bianchi quell’aurea di superiorità che li aveva contraddistinti, in passato, ai loro occhi. Quale superiorità – si chiedevano gli indigeni – poteva avere un uomo bianco che chiedeva agli africani di uccidere i suoi fratelli di razza?
L’analisi dell’Autore mostra come i resoconti dei missionari, fino all’inizio degli anni ’60, manifestassero la convinzione della superiorità assoluta della propria cultura di fronte ai “selvaggi” che dovevano essere formati e “addomesticati”.
Gli indigeni dovevano far propria la cultura del missionario, mentre raramente vi era, da parte di quest’ultimo, una conoscenza approfondita della cultura dell’altro: semplicemente, essa non contava ai suoi occhi.
Questa forte presunzione della superiorità della cultura occidentale rispetto a quelle africane e asiatiche, avrebbe avuto conseguenze importanti sulle relazioni ecclesiali successive.
Nuove prospettive dell’evangelizzazione
Ci volle il salutare scossone del Concilio Vaticano II per diffondere su ampia scala una concezione antropologica della cultura, la necessità di studi missionologici e una preparazione adeguata dei missionari, al fine d’intessere con i popoli relazioni corrette e feconde. L’Autore, in conclusione, lascia aperti gli interrogativi sorti sul senso della missione.
I documenti magisteriali post-conciliari sulla missionarietà nella Chiesa cercano di indicare un equilibrio tra il concetto teologico della “missione”, costitutiva della Chiesa stessa, e l’essere mandati ad gentes per l’evangelizzazione, che abbraccia le diverse dimensioni storiche di essa, fra le quali l’inculturazione. Ricordano, nel riconoscimento degli errori commessi, l’importanza dell’andare ad gentes e verso le periferie geografiche ed esistenziali dell’umanità.
L’analisi del passato oggi è possibile con equilibrio e serenità. Ma rimangono gli interrogativi sul presente: se vi sia la capacità di fare spazio all’Altro nella sua recezione originale del cristianesimo nei Paesi di missione, oggi marcati da una forte indigenizzazione del clero.
È legittimo chiedersi, più globalmente, se sapremo confrontarci in profondità con le loro Chiese, senza utilizzarli solo come nuova manovalanza; e se loro stessi, memori delle sofferenze del proprio popolo, saranno capaci di autentica inculturazione e di novità evangelica.
23/01/2020




