La figura di don Giulio Facibeni
Una delle affermazioni che meglio definiscono la figura di don Giulio Facibeni è quella attribuita al pittore italiano di arte sacra e grande ritrattista Pietro Annigoni, che aveva con il sacerdote una personale amicizia: “Dopo aver visto gli occhi di don Giulio Facibeni, non si può dubitare dell’esistenza di Dio”[1].
Occhi vivissimi in un corpo minuto che, stanco e malato, dimostrando più anni di quanti ne avesse, custodiva una figura da gigante che aveva segnato in maniera indelebile la storia di Firenze, diventando un personaggio fondamentale della Chiesa locale e non solo.
Don Giulio Facibeni nacque a Galeata (allora provincia di Firenze e oggi di Forlì-Cesena) il 29 luglio del 1884; penultimo di undici figli di un padre calzolaio e di una madre casalinga, maturò la sua vocazione in un ambiente familiare in cui apprese la carità di non chiudere mai la porta a un bisognoso, l’interesse per i problemi sociali, l’amore per lo studio, la fede che nasce e si forgia soprattutto nella dura fatica e nel dolore.
Fondò a Rifredi, il quartiere di Firenze dove si trovava la sua parrocchia, l’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, inizialmente per accogliere orfani di guerra i cui padri, da cappellano militare, aveva assistito sul Monte Grappa, durante la Prima guerra mondiale, con una dedizione che gli valse la Medaglia d’Argento al Valor Militare e la Croce d’onore austriaca, “in ringraziamento della pietà cristiana rivolta ai soldati nemici”. Con il passare del tempo l’Opera crebbe diventando punto di riferimento per bambini e adulti in difficoltà, offrendo loro assistenza educativa, sanitaria e sociale, e si estese moltiplicando le sue case in altre aree geografiche.
Nel 2024 l’Opera ha compiuto cento anni ed è, ancora oggi, una realtà caritativa e sociale al servizio dei più poveri, degli ultimi, delle nuove sacche di povertà. È presente anche in Brasile e Albania, con il compito di evangelizzare attraverso la carità e arrivare al cuore dell’uomo.
Un’umanità, quella di Facibeni o del Pievano, come lo chiamavano, che nel corso della sua vita si donò al massimo e si espresse fino alla lenta e progressiva consumazione, marcata negli ultimi 14 anni dal morbo di Parkinson che ne ridusse le forze al limite estremo, costringendolo alla totale dipendenza.
Le sue innumerevoli lettere, gli itinerari della sua vita da lui stesso descritta o raccontata, le testimonianze di chi l’ha conosciuto o profondamente studiato, immergendosi nell’enorme materiale minuziosamente archiviato, evidenziano numerosissimi, svariati e personalissimi rapporti che aveva nel mondo della cultura, dell’aristocrazia e del popolo, con i sacerdoti, i religiosi e gli operai. Si rimane veramente sconcertati da tanta energia in questo “povero facchino della Divina Provvidenza”, come soleva definirsi, preso da una vita vertiginosa, frenetica, con il solo fine di amare. Perché è questa l’unica chiave di lettura che chiarisce quello che umanamente sarebbe inspiegabile.
profondamente studiato, immergendosi nell’enorme materiale minuziosamente archiviato, evidenziano numerosissimi, svariati e personalissimi rapporti che aveva nel mondo della cultura, dell’aristocrazia e del popolo, con i sacerdoti, i religiosi e gli operai. Si rimane veramente sconcertati da tanta energia in questo “povero facchino della Divina Provvidenza”, come soleva definirsi, preso da una vita vertiginosa, frenetica, con il solo fine di amare. Perché è questa l’unica chiave di lettura che chiarisce quello che umanamente sarebbe inspiegabile.
Ci si domanda quando don Giulio riuscisse a “staccare”, quando permettesse al suo esile fisico un riposo tranquillo. Nonostante la sua instancabile operosità, era un uomo di una spiritualità eccezionale, un contemplativo in azione che affermava: “A cosa valgono tutte le parole degli uomini in confronto di un minuto di silenzio con Gesù? Se potessimo sempre sentirci ombra di lui!”.
Fu un mistico senza aver mai ricevuto grazie particolari. La sua non era ansia, né iperattivismo di chi gioca tutto sulle sue sole forze; anzi, aveva una fede incrollabile nella Divina Provvidenza, pienamente convinto che davvero tutto dipendesse da Dio, ma si impegnava fino allo stremo delle sue forze, come se tutto dipendesse da lui.
I poveri, gli ultimi, gli abbandonati da tutti, trovavano posto sicuro nel suo cuore, un cuore immenso che si dilatava sempre più e nel quale entravano tutti, in uno spazio infinito: bambini, giovani, anziani, operai, carcerati…, più ne incontrava e più si prodigava ad accoglierli, e le critiche si moltiplicavano: “Mette troppa carne al fuoco, è una pazzia, bisogna pur avere i piedi per terra…”. Infatti, il suo orizzonte pastorale è enorme, in ogni suo settore si sarebbe potuta impegnare un’intera vita.
Don Giulio era un uomo coraggioso che non temeva di proclamare la verità, non aveva paura, non rimaneva in silenzio, operava apertamente le sue precise scelte sempre a favore dei poveri e degli ultimi.
Ai disordini, agli arresti, alle lotte tra fazioni politiche nemiche, alle irruzioni, agli spari, alla disoccupazione, alla miseria presente nelle case, ai nuovi rapporti tra capitale e lavoro da cui germinava una nuova coscienza nella società, don Giulio rispondeva denunciando le responsabilità di chi, dopo fiumi di discorsi retorici sul popolo forte e coraggioso massacrato in guerra, si dimenticava delle tante promesse fatte e mirava solo al proprio guadagno personale[2].
Ebbe il coraggio di affrontare il potere, continuando a esercitare la sua missione al di sopra di tutte le forze politiche per difendere quel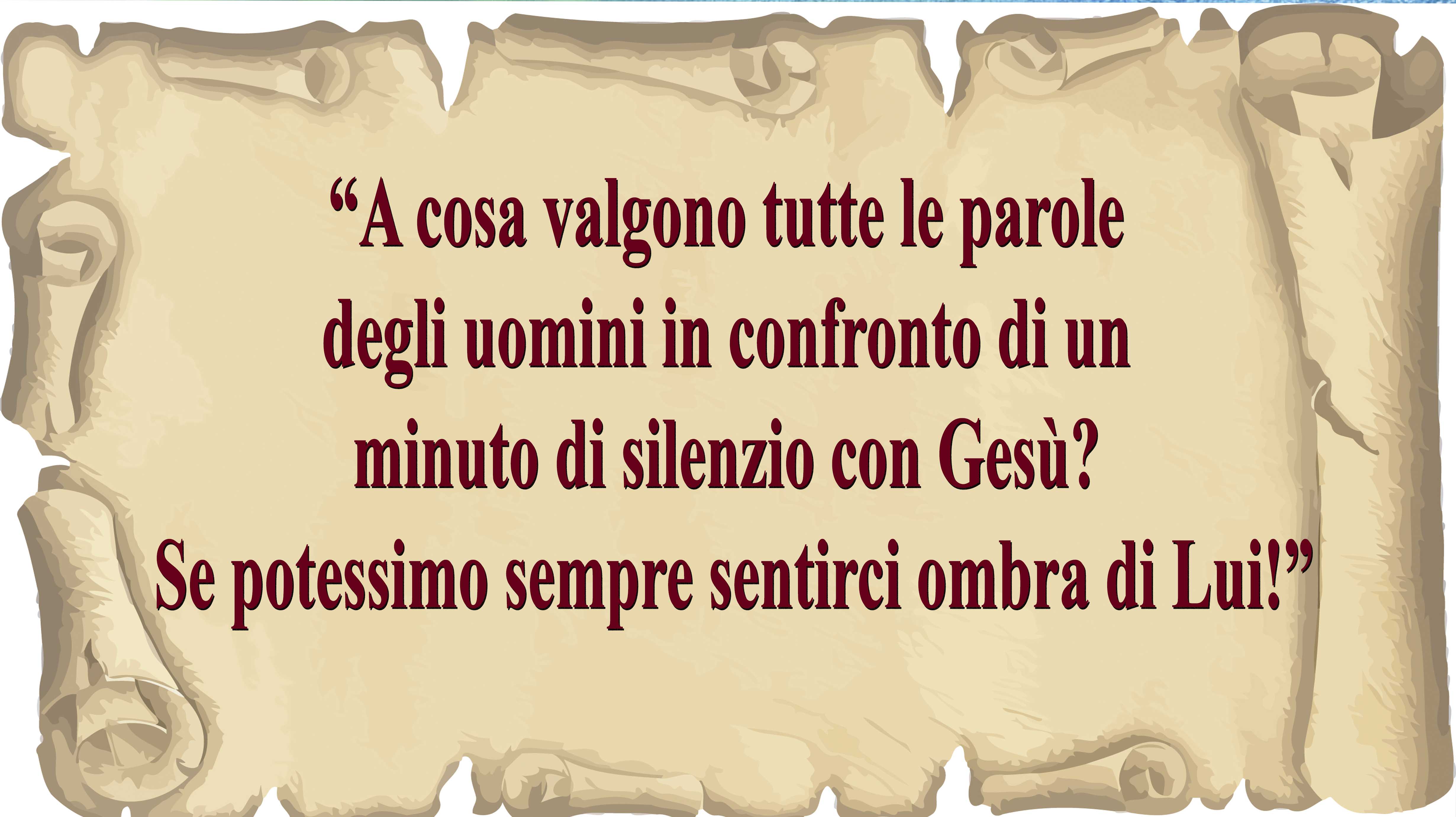 popolo che veniva “stordito, esaltato con parole, ingannato e tradito”, invece che amato e servito. In tante delle sue innumerevoli lettere scritte dal fronte, rifletteva sui vari movimenti e interventi bellici, nei quali vedeva chiaramente i secondi fini: le lotte meschine dei partiti e delle persone che non rinunciavano ai loro egoismi e ai loro rancori, senza pensare a chi immolava tutto, anche la vita.
popolo che veniva “stordito, esaltato con parole, ingannato e tradito”, invece che amato e servito. In tante delle sue innumerevoli lettere scritte dal fronte, rifletteva sui vari movimenti e interventi bellici, nei quali vedeva chiaramente i secondi fini: le lotte meschine dei partiti e delle persone che non rinunciavano ai loro egoismi e ai loro rancori, senza pensare a chi immolava tutto, anche la vita.
Al dramma delle due guerre mondiali non volle mai dare delle spiegazioni solo politiche, e non poteva rimanere soddisfatto da dichiarazioni accademiche di ordine militare; vi leggeva piuttosto il mistero dell’uomo avvolto nel peccato che ha bisogno di salvezza e conversione. Per questo, indossando la sua talare nera, esercitò il suo ministero come cappellano militare: “Finché gli uomini tutti non vivranno la divina parola del Vangelo, la pace sarà un’utopia o una menzogna”.
L’Opera di don Giulio
C’è la guerra – durante la quale si impegna, oltre che nella Resistenza, a favore degli ebrei perseguitati, fino a essere riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” –, c’è il dopoguerra non meno sofferto, ma la sua unica bandiera rimane il Crocifisso. È con questa bandiera che, come attesta don Silvano Nistri nella sua Vita di don Giulio Facibeni, riesce a creare nelle ore più buie del Getsemani le sue Opere più belle e grandiose[3].
Quando i primi orfani entrano nella casa dell’Opera della Divina Provvidenza, don Giulio ha sempre più chiaro che l’impegno dell’Opera deve diventare impegno di tutto il popolo, dal più piccolo al più anziano, l’Opera deve vivere unicamente della generosità della gente che partecipa, magari anche “con una piccolezza”. Ognuno potrà dire: “Anch’io ho messo la mia pietra”. È un popolo che si fa mendicante per l’Opera. Al di sopra di ogni lotta di parte, don Giulio riesce a mettere al centro il povero da amare, muovendo tutta la parrocchia che diventa sempre più missionaria, superando anche i confini di Rifredi.
E gli orfani aumentano di numero, moltiplicandosi: 500, 800, 1200, e cresce tutta l’Opera. Come gestirla?
Aveva discorsi chiari sulla formazione integrale degli orfani, sull’orfanotrofio che non doveva essere un collegio. Aveva sempre 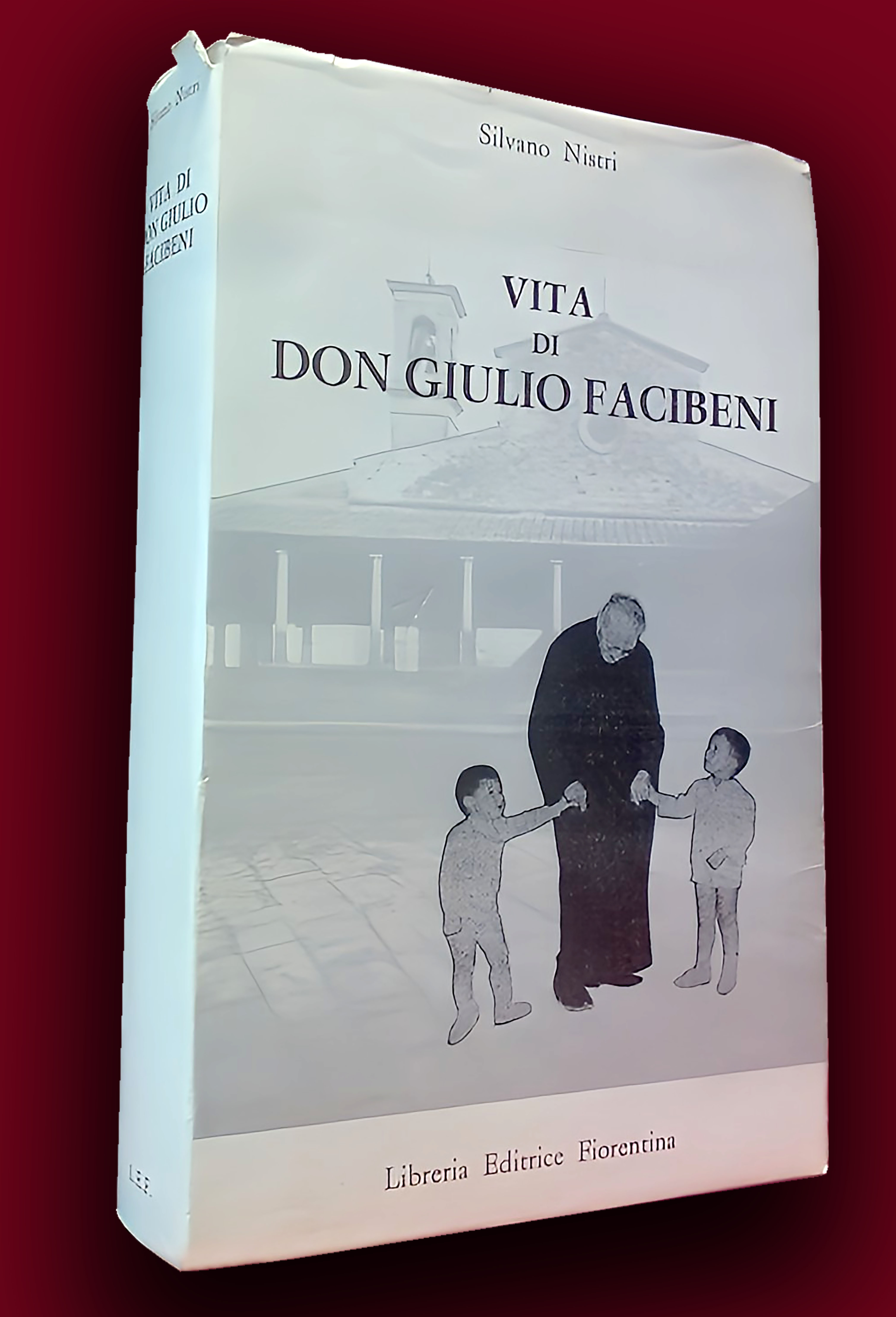 pensato al concetto di collegio con un senso di repulsione. Il problema dell’educazione, insieme alla formazione umana, culturale, professionale e religiosa, è rimasto sempre centrale per don Giulio: far sentire ai giovani la loro dignità e responsabilità, far capire loro che “il mondo si ferma alle apparenze, tenta scimmiottare, ma le opere del mondo sono senza anima: poveri castelli di carta che il primo urto sfascia”. Ebbe il coraggio di chiedere a ognuno di restituire a Dio tutto quello che aveva ricevuto: doni di natura e grazia, povertà e ricchezza, anima e corpo, e prometteva che Dio li avrebbe investiti per i suoi disegni, facendo gustare la gioia piena di collaborare con Lui.
pensato al concetto di collegio con un senso di repulsione. Il problema dell’educazione, insieme alla formazione umana, culturale, professionale e religiosa, è rimasto sempre centrale per don Giulio: far sentire ai giovani la loro dignità e responsabilità, far capire loro che “il mondo si ferma alle apparenze, tenta scimmiottare, ma le opere del mondo sono senza anima: poveri castelli di carta che il primo urto sfascia”. Ebbe il coraggio di chiedere a ognuno di restituire a Dio tutto quello che aveva ricevuto: doni di natura e grazia, povertà e ricchezza, anima e corpo, e prometteva che Dio li avrebbe investiti per i suoi disegni, facendo gustare la gioia piena di collaborare con Lui.
Non siamo chiamati alla mediocrità e l’amore non si nutre di sogni, ma di sacrifici compiuti. Don Giulio non ha mai ingannato i giovani promettendo loro onori, consolazioni, soddisfazioni, ma, piuttosto, umiliazioni e sacrifici.
Chiaramente faceva capire che non aveva nessuna intenzione di essere considerato il direttore di un pensionato dove si viveva senza pagare; voleva formare una comunità-famiglia e per farlo era capace di diventare anche molto duro, soprattutto con chi era ingrato dopo tutto quello che aveva ricevuto. Sapeva, se necessario, usare l’arma dell’espulsione, con fermezza, dignità e correttezza, in modo che la persona espulsa non avanzasse nessuna rivendicazione[4].
“Coloro che architettano fughe, non pensino di trovare indulgenza. È ora che comprendano che non si può chiedere agli altri tutto il sacrificio, per fare poi il proprio comodo. Se non vogliono starci o non hanno voglia di studiare, lo dicano francamente e pari pari si rimandano alle loro case”[5].
In un tempo in cui ci confrontiamo continuamente con esempi di genitori che difendono a spada tratta i figli, allontanandosi da ogni più elementare principio educativo, l’insegnamento di don Giulio è più che attuale.
A un giovane che ne aveva combinate parecchie, che era stato più volte perdonato e che gli chiedeva aiuto per sfuggire alla polizia, era capace di chiudere la porta per porlo di fronte alle sue responsabilità. Dopo che si era veramente fatto tutto a tutti, determinato, con profondo rispetto, a non entrare mai di forza nel cuore dell’altro, era anche capace di arrivare a definitive conclusioni: “Io non so più che dirti”.
Guardava al passato con la coscienza di aver donato tutto, senza riserve e senza eccezioni, assumendosi in pieno le responsabilità e pagando di persona prezzi altissimi. “Carità e Giustizia. Come è difficile combinarle insieme! La mitezza senza la forza diviene debolezza: la forza senza la mitezza diviene tirannia. Soltanto la grazia può combinare meravigliosamente i due termini”, scriveva a uno dei suoi figli più cari.
Un uomo autentico
Di fronte alla figura di don Giulio, riletta oggi a quasi settant’anni dalla morte, ci si domanda quale sia l’attualità della sua vita, quali i punti di contatto del suo impegno pastorale con i nostri problemi odierni, quelli della Chiesa e delle parrocchie che si vanno sempre più svuotando.
Cosa lo lega a un mondo che oggi cambia a una velocità pazzesca, mentre la distanza tra le generazioni si fa sempre più ampia, accentuandone i conflitti e le incomprensioni?
accentuandone i conflitti e le incomprensioni?
L’uomo moderno è un “orfano” senza precedenti nella storia perché, dopo la morte di Dio, è subentrata la morte del prossimo, e questo ha portato alla scomparsa della seconda relazione indispensabile all’uomo – l’altro – facendolo cadere in una sostanziale solitudine nonostante la miriade di relazioni virtuali[6]. Come canta una band tedesca: “Posto, dunque sono…, ma degli oltre mille amici di Facebook, non ne ho mai visto uno”[7].
Anche don Giulio, come molti di noi, in contatto con le difficili problematiche dei suoi giovani, viveva la nostalgia dei suoi tempi e confidava a un suo amico nel 1934:
“Per me è una pena vedere che i giovani non si interessano più di questioni sociali: ripenso ai miei anni giovanili… entusiasmi troppo spinti, non idee precisate, ma in fondo si sentiva che il cuore ardeva per una causa di giustizia, per una maggiore equità nei rapporti sociali”[8].
Il divario generazionale e il mutamento socioculturale esistevano anche ai suoi tempi, così come esisteva la ricerca di metodi pastorali che arrivassero a raggiungere il grido dell’umanità sofferente e a svolgere un apostolato da anima ad anima. Sul suo bollettino “Vita Parrocchiale”, che portava avanti con sforzi micidiali e mezzi precari, e che sarebbe diventato il settimanale della diocesi di Firenze, scriveva:
“Noi sacerdoti dobbiamo aggiornare un poco i nostri antichi metodi di apostolato, dobbiamo uscire dalle nostre sacrestie per andare dove si lotta, si soffre, si lavora. Guai se il sacerdote si fossilizzasse in certe forme di apostolato ormai non corrispondenti al nuovo fremito di vita”.
Queste parole richiamano l’appello di Papa Francesco che ci ha indicato le periferie fisiche e spirituali del mondo di oggi.
Tuttavia, per quanto l’attenzione di don Giulio Facibeni rimanesse vigile nella ricerca di vie riattualizzate di apostolato, egli sapeva bene che qualsiasi programma di rinnovamento pastorale è condannato al fallimento, se non si è disposti a vivere in primis il Vangelo che si annuncia agli altri. L’apostolato non certo come tecnica, ma come spirito.
(Continua)
_________________
[1] M. Bertini, Fui anch’io uno dei suoi figliuoli, in S. Piovanelli, Don Giulio Facibeni “Il povero facchino della Divina Provvidenza”, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2008, 132.
[2] Cfr. S. Piovanelli, Don Giulio Facibeni…, 47.
[3] Cfr. S. Nistri, Vita di don Giulio Facibeni, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1979, 194.
[4] Cfr. Lettere di don Giulio Facibeni. A cura di S. Nistri - F. Righini, I, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1979, 60.
[5] Lettere..., 81.
[6] Cfr. O. De Bertolis, La solitudine dei giovani, in “La Civiltà Cattolica” 175/I (2024) 530.
[7] Cfr. O. De Bertolis, La solitudine…, 528.
[8] Lettere di don Giulio Facibeni. A cura di S. Nistri - F. Righini, II, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1979, 560.
28/09/2025




